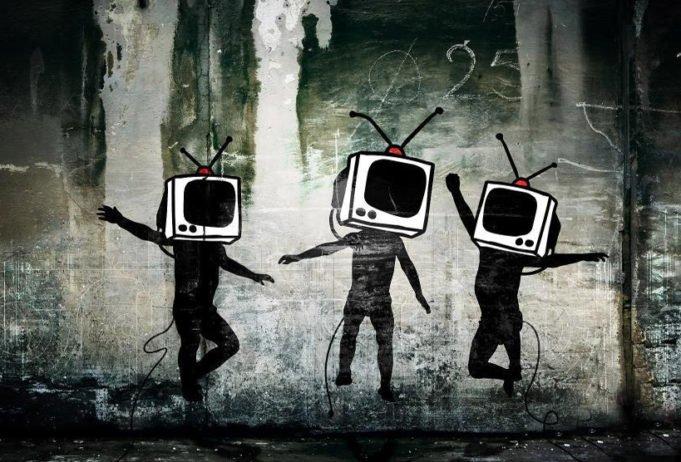Il Senato ha approvato ieri la fiducia al Decreto Lavoro. Con questa norma sostanzialmente si smantella il reddito di cittadinanza, una misura fondamentale di sostegno ai nuclei in povertà. Si introduce l’assegno di inclusione, di importo e durata minori, ma solo per le famiglie in cui non vi siano componenti con necessità di cura. Tutti gli altri dovranno darsi da fare nel mercato del lavoro
L’intento dichiarato esplicitamente nella discussione al Senato è che il lavoro e il salario che si percepisce tornino a costituire l’autentico reddito di cittadinanza. Come viene argomentata questa politica?
Sostanzialmente attraverso l’assunzione che chi è povero non lavori perché non vuole farlo. Emblematica è la dichiarazione di una esponente della maggioranza secondo la quale i percettori del reddito di cittadinanza hanno ricevuto l’aiuto pubblico senza essersi mai attivati per trovare un impiego anche se potevano farlo. In sostanza dietro questa scelta c’è una visione della povertà come risultato di una responsabilità individuale. Una visione tutt’altro che nuova.
Già nel 1978 Margaret Thatcher definì il problema della povertà estraneo alle responsabilità del governo nei paesi occidentali. La causa della condizione di indigenza è piuttosto da imputare alla mancanza di personalità degli individui. In altri termini, se le persone vivono in povertà è in gran parte colpa loro perché non hanno carattere.
Questa concezione del fenomeno della povertà è semplicistica, fuorviante e grottesca. Senza entrare nel merito della complessità delle dimensioni e delle dinamiche che portano in Italia circa 5,6 milioni di individui a non avere le risorse necessarie per vivere con uno standard di vita minimo, ci limitiamo qui a considerare il legame tra povertà e lavoro. Secondo gli ultimi dati Istat sono 3,4 milioni le persone in età compresa tra i 18 e 64 anni a essere povere e potenzialmente occupabili. In realtà più di un quarto sono occupate e sono quindi lavoratrici e lavoratori poveri. Gli altri? Inattivi e disoccupati. I primi non cercano lavoro e se anche glielo offrissero lo rifiuterebbero. Fannulloni? Forse alcuni, ma la stragrande maggioranza sono donne con carichi di cura. I secondi sono i cosiddetti occupabili. Uomini e donne che cercano un impiego e se non lo cercano, perché scoraggiati dopo tanti mesi senza lavorare, sarebbero comunque disponibili ad accettarne uno. Ecco, si potrebbe concludere che loro sì, sono colpevoli per la loro condizione di povertà. In realtà, prima di trarre qualsiasi conclusione, va sempre considerata l’offerta di lavoro insieme alla domanda.
La realtà è che, a fronte di 2 milioni di disoccupati nel nostro paese, sfaticati o no, non c’è un numero sufficiente di occupazioni per tutta la richiesta che c’è. Detto altrimenti, manca il lavoro.
Dunque, tra le persone che vivono in povertà molte lavorano, una parte non può essere occupata e una parte vorrebbe lavorare ma non trova lavoro. Su cosa si basa questa politica allora? Sulla presenza di alcuni che scientemente non vogliono lavorare e colpevolmente godrebbero di soldi pubblici. Presenza che però, guardando ai dati, è residuale. D’altro canto, dargli molto enfasi consente di non affrontare problemi più ostici per un governo: aumentare l’occupazione e migliorare le condizioni di lavoro. Insomma, più facile smantellare il reddito di cittadinanza anziché realizzare politiche di sviluppo, industriali e di buona occupazione, adeguatamente retribuita.
MARIANNA FILANDRI